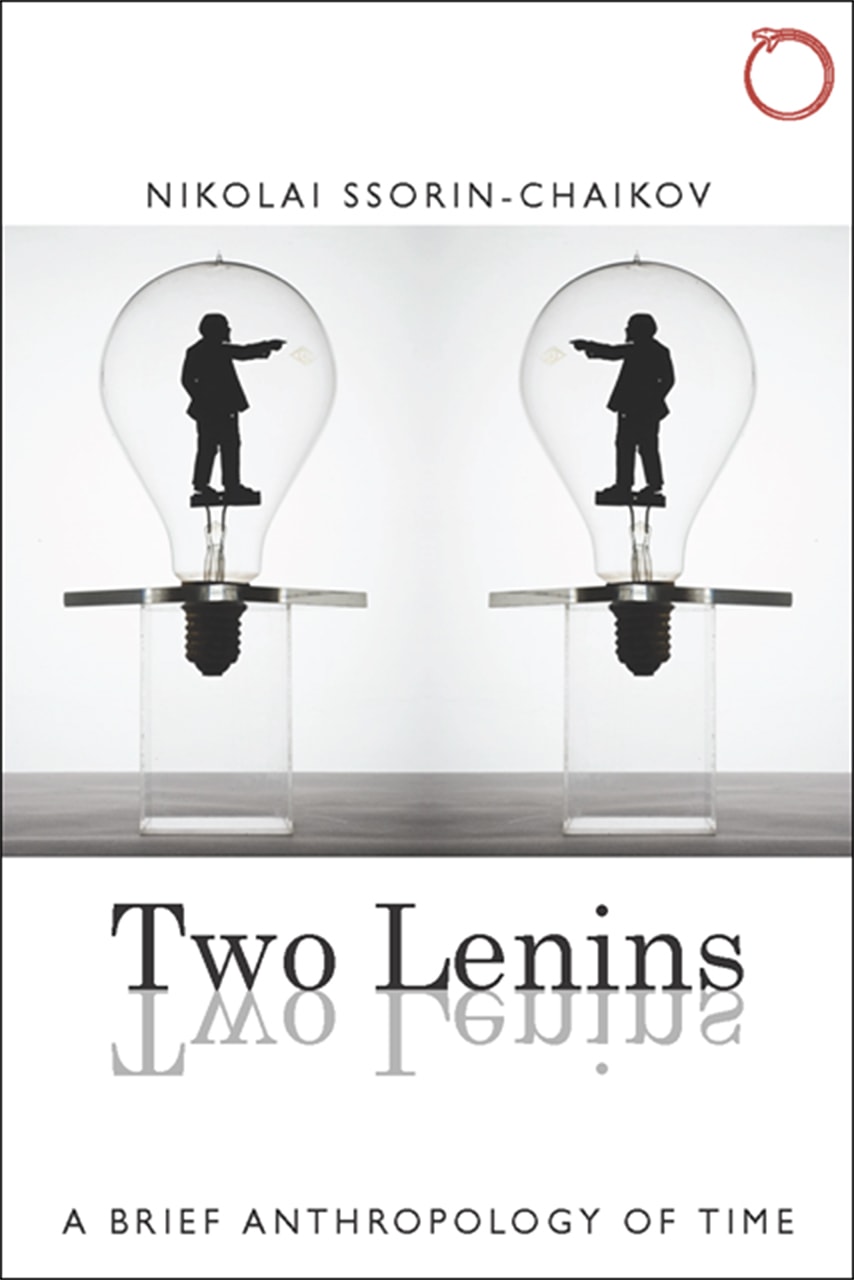Nell’ambito della nostra rubrica
“Non di dinosauri, non di stelle ma…
raccontiamo grazie a Corinna Guerzoni, antropologa e ricercatrice presso il Western Fertility Institute di Los Angeles come è possibile, grazie all’antropologia, occuparsi di
…di medicina e surrogacy “
A cosa serve l’antropologo nel contesto in cui lavori tu?
All’interno della clinica, rivesto il ruolo di ricercatrice/antropologa. Ho costruito un progetto di ricerca triennale su surrogay, terze parti riproduttive e nuove forme di genitorialità. Sto proseguendo il lavoro come ricercatrice, nel senso che continuo a fare etnografia come quando ero dottoranda. Le attività sono pertanto simili: “studio”, scrivo articoli e cerco di proporre il mio lavoro a varie conferenze. Posso però articolare meglio il mio pensiero, partendo dalla risposta che il direttore dell’istituto aveva dato quando l’avevo intervistato rispetto all’interesse di ricerche a stampo non medico-clinico nel campo della procreazione medicalmente assistita:
“Troppo spesso aspettiamo che siano gli altri a lavorare per le nostre cause. Dimentichiamo che è nostra responsabilità far avanzare la cultura e le idee che noi valutiamo importanti. Come medico uso ricerche condotte da altri per determinare il miglior trattamento medico per i miei pazienti. È mia responsabilità far accrescere il corpo di ricerche su queste tematiche. […] La surrogacy come è stata praticata in altri paesi è sgradevole. Negli Stati Uniti, l’altruismo è una parte fondamentale del percorso. Quindi è nostro dovere far luce su questo argomento, nel bene e nel male, attraverso ricerche come quelle che stai conducendo tu Corinna.”
Da questo punto di vista, le conoscenze che un antropologo studia, analizza ed elabora vengono utilizzate all’interno dell’istituto. Il sapere critico dell’antropologia può sicuramente contribuire a mettere in discussione certe pratiche, modi di agire ed offrire spazi di riflessione. Lo sguardo dell’antropologo può quindi servire ad immaginare e costruire nuove prassi. Mentre scrivevo il progetto, ho pensato all’importanza delle illness narratives di Arthur Kleiman e a quelle di alcune etnografie proprie dell’antropologia medica. 
Ti senti accettata, o cosa stai facendo per il riconoscimento della tua professione?
E’ sempre complesso spiegare, ma soprattutto far capire cosa significhi “fare etnografia” fuori dalle mura accademiche. Intervistare, studiare o semplicemente osservare le dinamiche delle persone che attraversano gli spazi di una clinica, sono certa possano sembrare attività lontane dal loro orizzonte di senso che è volto a seguire i pazienti nei frammentati percorsi riproduttivi, da un punto di vista clinico.
Non hanno mai avuto una ricercatrice all’interno e vedermi studiare per la maggiorparte del tempo penso possa essere destabilizzante. Una collega ha passato tutta la prima settimana ad entrare ogni mezzora nel mio ufficio per chiedermi come stesse procedendo la ricerca. L’ho trovato un episodio particolarmente ironico. Mi interfaccio quotidianamente con la cultura del “tutto e subito”; sono poco, anzi direi per nulla abituati al sapere lento dell’antropologia. E’ un lavoro lungo e delicato, soprattutto perché i ritmi di lavoro sono sicuramente differenti. Stiamo imparando a conoscerci a vicenda, dobbiamo adattarci gli uni agli altri, ma penso capiti forse sempre così in un nuovo posto di lavoro.
Come è percepito l’antropologo all’estero? Da cosa credi che dipenda, ovvero quanto la comunità di antropologia è riuscita a fare conoscere la disciplina ed eventualmente la professione?
Anche se con alcune solite piccole resistenze, è sicuramente una professione molto più ultilizzata nel mondo del lavoro. Questo a vari livelli, sia in ambito sociale che medico/clinico. Ci sono antropologi che si occupano di mostre museali oppure ci sono antropologi che vengono assunti per svolgere ricerche in varie realtà lavorative, ad esempio, in ospedali o enti di ricerca.
Ma sicuramente una grande fetta di antropologi riveste il ruolo di docenti e questo credo sia uno dei motivi per i quali, forse, la professione è riconosciuta e ricercata. Come saprai, in Italia nemmeno con un Dottorato in Antropologia puoi accedere all’insegnamento.
L’antropologia applicata e professionale è possibile?
Certo, anche se credo che il lavoro dell’antropologo fuori dalle università sia ancora in fase di definizione e possiede numerose sfaccettature. C’è chi fa ricerca come me, e al contempo cerca di offrire i propri strumenti all’interno di un’attività lavorativa, e chi forse fa un lavoro come l’educatore (esempio a caso) cercando di applicare i saperi acquisiti durante la formazione universitaria. Se l’antropologia è, come diceva il caro professor Fabietti, un sapere di frontiera che ha il compito di gettare un ponte tra culture, direi però che fare l’antropologo non debba ridursi ad essere solo un lavoro a ponte tra due professioni.
Cosa diresti a un giovane studente di antropologia?
Il percorso potrà sembrare non facile, tortuoso e spesso senza una meta ben definita. Ricordo ancora le parole che il Professor Malighetti aveva suggerito a noi studenti del primo anno di antropologia: “Dovete avere un progetto ambizioso, senza essere voi stessi ambiziosi”. Le potenzialità dell’antropologia sono molte, l’astuzia forse sta nel sapere comprendere quali strade percorrere, come costruire una rete e individuare un terreno accogliente un sapere critico qual è quello dell’antropologia.
Grazie Corinna e auguri!
Nicoletta e Valentina