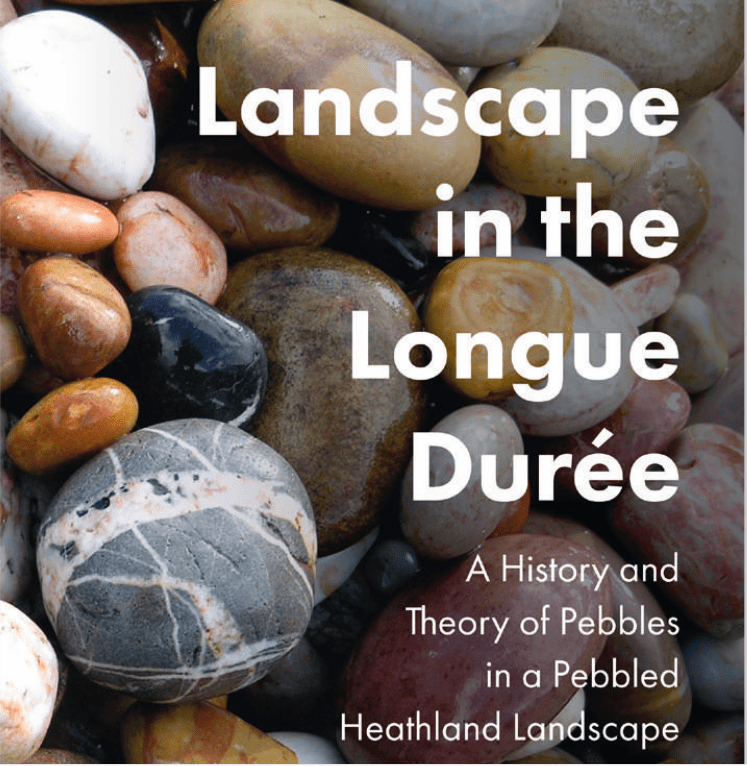Di Viola Castellano
Il 4 dicembre 2019 un naufragio al largo delle coste della Mauritania costò la vita a 63 persone, tutte di nazionalità gambiana, tutte molto giovani. La barca era partita da Barra, una piccola cittadina di pescatori sulla costa nord del Gambia, e aveva come destinazione le isole Canarie. Lo scafo si era danneggiato, aveva cominciato a imbarcare acqua e i soccorsi non erano riusciti ad arrivare in tempo per effettuare un salvataggio completo. La riapertura della cosiddetta “rotta atlantica” della migrazione “irregolare” verso l’Europa, utilizzata in passato ma abbandonata per la sua pericolosità, era una conseguenza diretta della chiusura di quella del Mediterraneo Centrale, a seguito del rafforzamento e dell’esternalizzazione dei confini europei nei vari stati di transito come Niger, Algeria e Libia. Io mi trovavo poco lontano, a Serrekunda, dove stavo conducendo una parte del mio campo multisituato sull’impatto delle politiche migratorie e di asilo europee sulla recente migrazione dal Gambia all’Italia. Mentre camminavo nelle strade di Serrekunda, i miei interlocutori mi indicavano le case e le famiglie dei giovani morti o dispersi nel naufragio.
Queste riflessioni nascono anche da questa esperienza, di cui sono stata una testimone fugace, ma che mi ha spinto ulteriormente a mettere in discussione il mio posizionamento, sia come ricercatrice che come ex-operatrice nel sistema di asilo, rispetto ai temi centrali della ricerca e alla responsabilità di produrre conoscenza sugli stessi, in un contesto in cui l’accesso alla mobilità è così violentemente ineguale e razzializzato [1]Con razzializzazione indico il processo tramite il quale fenomeni quali il diseguale accesso alla libertà di movimento e/o le forme di deportazione/controllo/assistenza dei migranti e dei richiedenti asilo africani in Europa rafforzano ulteriormente forme di stratificazione sociale e gerarchie del valore (Herzfeld, 2004) basate anche sulla “linea del colore” (Du Bois, 2004), riproducendo dinamiche di razzismo strutturale.. Chiedendomi come procedere nell’etnografia, ripercorro narrativamente gli incontri e le contingenze che hanno generato e modellato la costruzione del campo, interrogandone i limiti e le opportunità epistemologiche ed etico-politiche [2]Una prima elaborazione di questo contributo è stata presentata alla conferenza EASA 2020 nel panel della Anthropology of Race and Ethnicity intitolato “”Whose Horizons: Decolonizing European Anthropology”. La ricerca di cui tratto nell’articolo è finanziata da FAPESP, borsa di post-dottorato n. 2018/22947-3. Le opinioni, ipotesi e conclusioni espresse in questo articolo sono di responsabilità dell’autrice e non riflettono necessariamente la visione di FAPESP..
Incontri, traiettorie e attraversamenti nel sistema di asilo
Ho incontrato M. una fredda mattina di febbraio. Lavoravo da quasi un anno come operatrice legale in un centro di accoglienza per richiedenti asilo in Italia e quel giorno mi ero recata in uno degli alberghi trasformati in struttura ricettiva gestita dall’ONG per cui lavoravo, per dare la cosiddetta “informativa legale” a un gruppo di persone arrivate il giorno prima, direttamente dopo il loro sbarco in Sicilia. Ricordo di averlo visto avvicinarsi all’ingresso con le sue gambe lunghe e magre, colpita dal modo in cui riusciva a malapena a muoverle una dopo l’altra, il viso sfigurato da una smorfia di dolore ad ogni piccolo passo.
Dopo avergli fornito l’informativa legale, ho chiesto cosa gli fosse successo. Il mio collega, che aveva fatto il turno di notte aspettando fino alle quattro di mattina il pullman con i nuovi arrivati, mi disse che M. aveva menzionato brevemente la Libia e il centro di detenzione per migranti dove era stato rinchiuso per quattro mesi. C’erano altre persone che arrivavano in cattive condizioni, ma le sue erano particolarmente preoccupanti e potevo leggere il panico negli occhi del mio collega, responsabile delle questioni sanitarie.
Per permettergli di occuparsi dei suoi numerosi compiti quel giorno, decisi di portare M. all’ospedale per ulteriori indagini. C’era una lunga fila al laboratorio di analisi del sangue e devo essergli sembrata molto impaziente, camminando avanti e indietro nel corridoio e chiedendo alle infermiere se fosse possibile saltare la fila viste le sue condizioni. Ma dovemmo rassegnarci a metterci in coda e ci sedemmo sulle sedie di plastica attaccate al muro. Nell’attesa iniziammo a chiacchierare e lui accennò quasi immediatamente alla disumanità a cui aveva assistito e di cui era stato vittima lungo la rotta del Mediterraneo Centrale. Da lì era poi passato a una discussione più astratta sui diritti umani e poi ancora sui principi filosofici dell’Illuminismo, una conversazione piuttosto inaspettata in un corridoio di un ospedale e da un interlocutore in quello stato di salute. Mi raccontò di essere stato professore di francese nella scuola di una missione cattolica a Serrekunda, in Gambia, e di aver condotto un programma radiofonico sull’educazione con il suo migliore amico e collega B., in cui criticavano le politiche sull’istruzione dell’ex presidente e dittatore Yahya Jammeh. Dopo alcune velate minacce da parte di funzionari governativi di alto profilo a proposito delle sue critiche al Presidente e per altri motivi personali piuttosto complessi, aveva deciso di andarsene. La sua storia venne interrotta dall’infermiera che chiamò il suo nome, pronunciandolo con manifesta fatica e irritazione. Alla nostra uscita dall’ospedale, entrammo in un caffè, ordinai la colazione per lui, mi sedetti su un tavolo e lo guardai dritto negli occhi mentre sorseggiava il suo cappuccino. “Hai una grande responsabilità qui, devi diventare un ponte, un mediatore”, dissi, senza tatto e senza tener conto delle sue condizioni fisiche. Il mio “sguardo bianco”, come avrebbe detto Fanon, aveva captato come la sua erudizione di stampo occidentale potesse essere estremamente utile nella lotta per i diritti dei migranti, in un contesto in cui i vicini del centro di accoglienza dove lavoravo si lamentavano perché dovevano vedere “tutti quei corpi neri” sui balconi davanti alle loro case.
Nelle settimane seguenti feci del mio meglio per cercare di alleviare per quanto potessi la sua condizione di sofferenza. Era in stato di shock e passava la maggior parte della giornata seduto con la testa tra le mani, fumando costantemente, mangiando pochissimo. Passavo in albergo a salutarlo alla fine del mio turno, portandogli gli unici libri in francese che riuscivo a trovare nella biblioteca pubblica, classici della letteratura. Una volta in cui avevo bussato alla sua porta per chiedergli informazioni su i suoi documenti, non era riuscito ad aprire per qualche minuto. Quando finalmente ci riuscí, i suoi occhi sembravano sul punto di schizzare fuori dalle orbite e il suo corpo era teso e irrigidito. Capii che il suo trauma era troppo profondo e fresco per potergli permettere di ricostruire una qualche vaga normalità e gli proposi di andare dalla psicologa che riceveva una volta a settimana gli utenti del centro. Ci andammo insieme, dopo sue ripetute insistenze per avermi come mediatrice linguistica, un ruolo che in quanto operatrice legale non avrei dovuto ricoprire. Non era raro però che le forme di sofferenza psichica dei richiedenti asilo emergessero proprio durante le nostre sessioni di preparazione al colloquio con la Commissione Territoriale, l’organo preposto a valutare la loro richiesta di asilo e a cui dovevano spiegare i motivi della loro fuga. Per questo motivo, dopo avergli consigliato un consulto psicologico, mi ritrovavo mio malgrado a fare da mediatrice linguistica nei colloqui con la psicologa, spinta dai richiedenti asilo stessi che volevano mantenere il maggior riserbo possibile sulla loro storia e dalla scarsità di personale nella ONG. Nel corso delle sedute, M. parlò di alcune questioni personali, ma non riuscì a parlare della Libia. Ancora oggi, dopo quattro anni, raramente lo sento parlare di quei quattro mesi. M. ottenne un permesso umanitario a causa delle sue condizioni psicofisiche, che poi riuscì a trasformare in un permesso di lavoro poco prima che i Decreti Salvini diventassero operativi. Dopo la fine del suo periodo come beneficiario nel sistema di asilo, ero riuscita a raccomandarlo come mediatore a un conoscente, coordinatore di una piccola cooperativa che gestiva l’accoglienza nella mia città natale. M. è ora il ponte che io, con una notevole mancanza di sensibilità e con un’urgenza politica strumentale, mi ero affrettata a far diventare fin dal nostro primo scambio all’ospedale. Oggi M. è un mediatore culturale molto rispettato, un attivista e uno stretto collaboratore dei migliori difensori legali per i richiedenti asilo della zona. Conosce la mia famiglia e i miei amici, che nel frattempo sono diventati suoi amici, alcune delle persone con cui condivide la sua quotidianità in una città in cui non vivo più da decenni. Quando torno e ci vediamo, ridiamo spesso del fatto che non riesco nemmeno a capire le sue indicazioni topografiche perché non conosco più i nomi delle strade. Con il tempo, i nostri posizionamenti nella relazione sono cambiati; il grado di libertà e di autonomia raggiunto da M. ci ha permesso di costruire un’amicizia, scegliendo il nostro rapporto invece di essere costretti ad accettarlo date le contingenze.
Vivere e testimoniare il ritorno
Nel novembre 2019 sono partita con M. per un continente, l’Africa, che non avevo mai visitato prima, per condurre una parte del lavoro sul campo previsto dalla mia borsa di postdottorato sulle ripercussioni delle politiche di asilo dell’UE sui migranti del Gambia. L’aereo era in ritardo e arrivammo intorno alle 3 del mattino all’aeroporto di Banjul. Mentre mi presentavo al suo amico B., che ci era venuto a prendere, persi di vista M. e mi volsi a cercarlo: eccolo là, con una bambina assonnata e imbronciata tra le braccia, con lo stesso tipo di lunghe gambe che pendevano dal suo abbraccio. M. cercava il suo viso e i suoi occhi, ma la bambina era troppo frastornata per capire cosa stesse succedendo e si sporgeva verso una donna, la madre, vestita con un abito tradizionale dorato, chiedendo di ritornare fra le sue braccia. Stavo assistendo al primo, impacciato incontro fra M. e la figlia, nata dopo la sua partenza.
Siamo andati a vivere tutti insieme in un appartamento che avevo affittato a Serrekunda. M. cercava di costruire un vero rapporto con sua figlia, che vedeva solo su Whatsapp dal giorno della sua nascita. La bambina sembrava accettare la sua presenza a intermittenza, come qualcuno che non riusciva a collocare nella propria esistenza. Ci vollero diversi giorni prima che la sua ragazza, ora moglie, iniziasse a parlarmi e si convincesse che tra noi non c’era altro che amicizia. In quelle settimane, prima di tornare in Italia per lavoro, M. era immerso in uno stato di ruminazione costante così intenso che mi sembrava di sentire il suono dei suoi pensieri. Parlavamo in balcone, fumando sigarette locali, della politica gambiana e italiana, del sistema di asilo, del suo ruolo in esso, facevamo paragoni, discutendo disordinatamente sui nostri diversi modelli di famiglia. Era combattuto su cosa fare, realizzando per la prima volta l’irreversibilità della scelta di lasciare il suo paese e la conseguente frammentazione identitaria, una sensazione che riuscì ad identificare e nominare come “doppia assenza” leggendo Sayad successivamente.
Quando andammo a visitare la sua ex scuola, i suoi colleghi rimasero stupiti e commossi nel vederlo, iniziando subito a lodarlo per le sue capacità di insegnante. La situazione mi era familiare, forse perché anche i miei genitori erano insegnanti e io ero abituata all’immancabile rievocazione nostalgica del passato quando incontravano per caso i loro ex allievi. Ma c’era qualcosa di strano, una dissonanza, qualcosa di profondamente inquietante. Immaginai allora che uno dei miei insegnanti del liceo, o uno dei miei genitori, sparisse a un certo punto, senza lasciare tracce. Immaginai che i miei compagni di classe e i nostri professori sussurrassero che forse era fuggito perché troppo critico nei confronti del governo. Immaginai che nessuno venisse particolarmente turbato, sorpreso, allarmato o preoccupato dalla notizia, assumendola come parte della realtà quotidiana. E immaginai come il mio professore, solo perché voleva stabilirsi in un altro paese, venisse sottoposto a violenze indicibili, fosse detenuto e picchiato, mangiato vivo dagli insetti e infine stretto con altre centinaia di persone su una barca precaria di legno o di gomma per attraversare il Mediterraneo senza alcuna certezza di sopravvivere. Immaginai che venisse salvato da persone coperte da tute bianche anti-contaminazione e trasferito in un albergo a caso nel bel mezzo di un paese sconosciuto e convivesse per mesi in una piccola stanza con altre due persone che non aveva mai visto prima, in una strana e stagnante attesa, aspettando di provare la legittimità della propria fuga. Lo immaginai accettare forzatamente la presenza e la relazioni con uomini e donne che non conosceva e di cui non riusciva a comprendere appieno le intenzioni, che lo istruivano svogliatamente sulla sua nuova condizione facendolo sentire poco più di un bambino. Lo immaginai poi trasferirsi in un’altra città, lavorare nella stessa macchina istituzionale che aveva appena vissuto e ritagliarsi lentamente il proprio spazio, le proprie relazioni, il proprio rispetto, la propria autonomia economica e professionale. E poi lo immaginai tornare a scuola un giorno, sorridere e ricominciare la propria lezione come se nulla fosse successo, tirandosi su le maniche della camicia e scrivendo la coniugazione del verbo essere in francese, come stava facendo in quel momento davanti a me. Mentre ero intenta a dispiegare questo scenario fittizio nella mia mente mi sorpresi a pensare alla sua assurdità. In seguito mi sono chiesta come tale sentimento di incredulità fosse di per sé basato sull’assunto silenzioso dell’impossibilità di invertire il nostro posizionamento nella gerarchia globale della mobilità e delle strutture transnazionali di potere che la sostenevano, normalizzate attraverso il paradigma umanitario o securitario.
Il differente posizionamento in questa gerarchia della mobilità e delle sue conseguenze, da cui ambiguamente dipendeva il nostro incontro, non turbava solo me. Quando M. mi presentava ad amici, parenti e conoscenti in Gambia, diceva che ero una ex collega, non la sua ex operatrice sociale. Inoltre, quando parlavamo del suo lavoro nel sistema di asilo, mi confessava il suo profondo disagio nel prendervi parte: i beneficiari, mi disse una volta, erano trattati più come corpi che come persone, entità biologiche che necessitano di saponi, vestiti e visite mediche.
Con il tempo, mi sono resa conto di come il processo di razzializzazione, disumanizzazione e vittimizzazione messo in atto dal regime di mobilità abbiano precluso la mia percezione di M. in Italia. Anche nella mia città natale, con lui a suo agio tra amici e colleghi, il nostro rapporto era sempre stato segnato da una specie di “divario epistemico”, cioè dal modo in cui ordini coloniali, razziali e di mobilità, nel creare le condizioni di possibilità del nostro primo incontro, avevano strutturato il modo in cui mi era stato possibile (ri)conoscerlo come soggetto. Me ne resi conto in Gambia. Osservarlo nel suo Paese, con la sua famiglia e i suoi amici, dipendendo da lui soprattutto nei primi giorni, cambiò la mia percezione della sua soggettività, che è infatti sempre data intersoggettivamente: in altre parole, corrispondeva più pienamente alla mia percezione non elaborata di una persona.
Ricerca o lavoro sul campo? Rifletter(si)e nel regime di mobilità
Ho proposto un intervento principalmente narrativo perché trovo che l’intreccio personale, affettivo, politico e geopolitico, razziale e governativo di questa narrazione sveli sia la molteplicità dei posizionamenti e dei ruoli possibili nel regime di mobilità[3]Con il termine regime di mobilità mi rifaccio alla definizione di Glick Schiller e Salazar: “Il termine “regime” chiama all’attenzione il ruolo dei singoli stati e delle mutevoli amministrazioni internazionali delle regolamentazione e della sorveglianza che condizionano la mobilità. Nello stesso tempo, il termine riflette le nozioni di governamentalità ed egemonia nelle quali è presente una costante lotta per capire, reclamare, incorporare, celebrare e trasformare categorie di somiglianza, differenza. appartenenza ed estraneità”.(Glick Schiller e Salazar, 2013, 32, mia traduzione). Molte altre definizioni sono state date dello stesso complesso di gestione della mobilità: è bene ricordare anche quello di Besteman “militarized global apartheid” (2019) o quello di “border regime” di De Genova (2016) , sia i suoi difficili attraversamenti. Spostarmi dal lavoro in accoglienza al lavoro etnografico non mi ha permesso di agire sulle gerarchie implicite e sul divario epistemico in cui mi sentivo drammaticamente intrappolata quando lavoravo in accoglienza, lo ha anzi amplificato, rendendolo ancora più tangibile, onnipresente e costantemente reiterato attraverso spazi, soggettività, congiunture e rappresentazioni, quindi attraverso le molteplici dimensioni in cui avviene l’etnografia.
Allo stesso tempo ho potuto essere testimone e toccare con mano le conseguenze umane della necropolitica [4]La nozione di Mbembe di necropolitica illumina come la violenza di stato venga messa in atto “per produrre la massima distruzione delle persone e di creare dei mondi di morte, forme nuove e uniche di esistenza sociale, nelle quali popolazioni intere sono assoggettate a condizioni di vita che equivalgono a collocarle in una condizione di “morti in vita”‘ (Mbembe, 2008, 76) . del confine, proprio grazie al mio lavoro di operatrice. Questo perché il mio era un lavoro di cura, ma all’interno di un sistema di presa in carico in cui riecheggiano forme di relazione coloniali, come hanno dimostrato diversi antropologi (Mayblin 2017, Bejarano, Juárez, García, & Goldstein 2019). Se la colonizzazione è stata anche una forma di assistenza, di educazione, di formazione morale delle persone che l’eurocentrismo pensa come “meno umane”, ci ricorda Mbembe, è difficile non vedere l’esperienza dell’accoglienza in Italia e in Europa anche attraverso una simile lente.
Ho deciso di continuare con l’esasperante precarietà del mondo accademico perché avevo bisogno di uno spazio per elaborare gli incontri e le situazioni travolgenti e intense che ho vissuto come operatrice sociale, e riflettere sulle loro ambiguità a partire dalla “comprensione affettiva” delle disuguaglianze globali che lavorare in accoglienza può stimolare. Quando l’Italia ha ristabilito i legami con la Libia per esternalizzare le frontiere e finanziare gli stessi centri di detenzione dove M. e molti altri che ho incontrato sono stati torturati, ricattati e costretti a vivere in condizioni disumane e quando sono state adottate misure sempre più repressive contro i migranti in tutta Europa, mi sono sentita ancora più spinta a testimoniare, osservare, pensare e descrivere alcune delle conseguenze di queste politiche. Ho pensato che la libertà intellettuale garantitami dal cambiamento della mia posizione da operatrice sociale nel sistema di asilo a etnografa sul campo, potesse mettere in discussione le profonde asimmetrie che avevano segnato questi incontri, o che almeno potessi trovare un modo per interrogarle, invece di assumerle semplicemente come la “normalità” in cui mi era stato chiesto di operare. Ma la mia posizione di ricercatrice sul campo non mi ha impedito di incorporare molteplici forme di disuguaglianza, emanate dalla mia mera presenza in quanto bianca ed Europea in Gambia, dalla mia capacità di movimento e di acquisto rispetto a quella della maggioranza delle persone che ho incontrato, dal mio status di ricercatrice e dal sistema istituzionale in cui la mia ricerca si situa e a cui si rivolge, cioè quello accademico occidentale. A questo pensavo mentre attendevo di imbarcarmi all’aeroporto di Banjul per l’Italia, tra gli Europei scottati dal sole che sorseggiavano le loro birre, mentre i corpi di giovani gambiani annegati mentre tentavano di raggiungere le Canarie pochi giorni prima dovevano ancora essere recuperati. Quale posizionamento possibile mi avrebbe permesso di criticare e denunciare le disuguaglianze globali della mobilità, mi sono chiesta, se sono la prima a beneficiarne? Come con la mia etnografia rischiavo di partecipare ancora una volta alla spettacolarizzazione del confine dalla mia posizione di privilegio? Infine, come costruire una etnografia capace di restituire la complessità e la capacità di agire dei miei interlocutori, senza accrescere le retoriche vittimizzanti e miserabiliste che anche l’antropologia più attenta ha riprodotto negli studi su rifugiati e migrazioni (Cabot 2019, Fassin 2011, De Sardan 2015)?
Se le ragioni che mi hanno spinto a fare questa ricerca possono far presumere la possibilità di una “solidarietà densa” -cioè “un tipo di solidarietà che mobilita l’empatia in modi che non sorvolano sulla differenza, ma piuttosto insistono sulla specificità, irriducibilità ed incommensurabilità delle esperienza razializzate” (Liu e Shange, 2018, 190, traduzione mia)-, i miei coinvolgimenti personali e professionali complicano allo stesso tempo ulteriormente la mia responsabilità nei confronti dei partecipanti alla ricerca, della produzione di conoscenza e della postura epistemologica ed etica attraverso cui costruisco l’etnografia.
Mentre procedo con la scrittura, mi chiedo come abitare il mio luogo, il luogo da cui parlo, e come fare ricerca antropologica possa esporre le congiunture storiche in cui essa avviene e che storicamente l’hanno resa possibile. Più volte, sia nel mio lavoro da etnografa che in quello da operatrice, mi sono interrogata sui dilemmi etici a cui assistenti e operatori sociali devono giornalmente rispondere, sottolineando la loro compartecipazione volontaria o involontaria alle dinamiche storico-politiche di cui ho parlato. Lavorare nell’accoglienza, con tutta la sua irriducibile complessità, mi ha dato l’opportunità di vivere e comprendere tali dilemmi in prima persona. Nel corso della mia esperienza lavorativa ho tentato di costruire un discorso sull’accoglienza e sull’incontro (Faier, Rofel 2014) insieme a degli interlocutori (altri operatori, richiedenti asilo) per ripensare l’attualità della nostra reciproca presenza, per trovare una meta-narrazione ed una via di fuga epistemologica che ci permettesse di oltrepassare lo schema relazionale e narrativo imposto dalla cornice istituzionale.
Le mie domande di ricerca muovono proprio dai limiti della natura dell’incontro che si dà fra operatori e richiedenti asilo, i cui ruoli reciproci vengono costruiti, oltre che dalla cornice istituzionale, dall’incontro stesso. Nel corso della mia esperienza di lavoro ho osservato come in questo incontro si manifestino le rigidità, incoerenze e forzature delle categorie, ma allo stesso tempo anche le loro porosità, svelando la molteplicità dei processi di significazione a cui ogni relazione, per quanto formalizzata e imbricata in un ordine politico più ampio, dà vita.
Senza questa esperienza e l’incontro con M. e molte altre persone, beneficiari come operatori, non avrei mai potuto imbarcarmi in una etnografia come quella che sto conducendo; per questo riconosco quanto l’esperienza mi abbia fornito un certo vantaggio epistemico, cioè una modalità di conoscere gli effetti del governo umanitario e del regime di mobilità da dentro e attraverso le mie stesse azioni all’interno delle sue infrastrutture. Questa esperienza mi ha però permesso di riconoscere anche come, nonostante le rigidità dell’infrastruttura, le soggettività di operatori e beneficiari si siano co-costruite, intrecciandosi e riverberandosi attraverso le molte dimensioni e i molteplici mondi che esistono dentro e nonostante i regimi di mobilità contemporanei.
Questo breve intervento vuole formulare domande e impressioni ancora in fase di elaborazione e non è in grado di fornire risposte. In questa incertezza, spero produttiva, sto cominciando a lavorare con M. su una possibile pubblicazione, pensando come la sua esperienza di vita, il suo doppio posizionamento da utente e operatore del sistema di accoglienza così come il mio da etnografa delle istituzioni e agente istituzionale, possano essere accostate nel modo più “pubblico” possibile. Nel districare questo intreccio ci sono anche dimensioni più personali e quasi psicoanalitiche. M., per esempio, mi ha chiesto di fare una breve descrizione della mia percezione di lui in Gambia, immagino per misurarsi attraverso le angolazioni dello sguardo dell’altro, e io gli ho chiesto di fare lo stesso con me. Per ora non siamo ancora riusciti a fare questo esercizio che presuppone un grado di intimità e svelamento che richiede tempo e disponibilità mentale, affettiva e relazionale, una cosa che la pandemia non sta certo facilitando. Non so come verranno utilizzate queste descrizioni, ma sono sicura che se verranno mai scritte entreranno a far parte delle ambiguità e opportunità epistemiche ed etiche di questa ricerca, come prodotti del regime di mobilità, del distorto gioco di specchi fra i suoi nodi e traiettorie, e degli indizi possibili sulle sue vie di fuga.
Viola Castellano è Postdoctoral Fellow della São Paulo Research Foundation ed è professore a contratto all’Università di Bologna. I suoi interessi principali ruotano intorno all’antropologia politica e all’antropologia delle istituzioni, la sua ricerca si concentra in particolare sulla produzione delle disuguaglianze e dei processi di razializzazione. Ha lavorato come operatrice legale nel sistema di asilo fra 2015 e il 2016.
Bibliografia:
Bejarano, Carolina Alonso, Lucia López Juárez, Mirian A. Mijangos García, and Daniel M. Goldstein. 2019. Decolonizing ethnography: Undocumented immigrants and new directions in social science. Durham: Duke University Press.
Besteman, Catherine. 2019. “Militarized global apartheid.” Current Anthropology 60, no. S19 (2019): S26-S38.
Cabot, Heath. 2019. “The business of anthropology and the European refugee regime.” American ethnologist 46, no. 3: 261-275.
De Genova, Nicholas. 2016. “The ‘crisis’ of the European border regime: Towards a Marxist theory of borders.” International Socialism 150 (2016): 31-54.
de Sardan, Jean-Pierre Olivier. 2015. “Methodological populism and ideological populism in anthropology.”In Epistemology, Fieldwork, and Anthropology, pp. 133-165. New York: Palgrave Macmillan.
Du Bois, William Edward Burghardt .2004. “Sulla” linea del colore”.” Studi culturali 1, no. 2 (2004): 297-300.
Faier, Lieba, and Lisa Rofel. 2014. “Ethnographies of encounter.” Annual Review of Anthropology 43: 363-377.
Fassin, Didier. 2011. Humanitarian reason: a moral history of the present. Berkeley: Univ of California Press.
Glick Schiller, Nina, and Noel B. Salazar.2013. “Regimes of mobility across the globe.” Journal of ethnic and migration studies 39, no. 2: 183-200.
Herzfeld, Michael. 2004. The body impolitic: artisans and artifice in the global hierarchy of value. Chicago: University of Chicago Press,.
Liu, Roseann, and Savannah Shange. 2018. “Toward thick solidarity: Theorizing empathy in social justice movements.” Radical History Review 2018, no. 131: 189-198.
Mayblin, Lucy. 2017. Asylum after empire: Colonial legacies in the politics of asylum seeking. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017.
Mbembe, Achille. 2008. “Necropolitiche.” Antropologia 8, no. 9/10.
Note
| ↑1 | Con razzializzazione indico il processo tramite il quale fenomeni quali il diseguale accesso alla libertà di movimento e/o le forme di deportazione/controllo/assistenza dei migranti e dei richiedenti asilo africani in Europa rafforzano ulteriormente forme di stratificazione sociale e gerarchie del valore (Herzfeld, 2004) basate anche sulla “linea del colore” (Du Bois, 2004), riproducendo dinamiche di razzismo strutturale. |
|---|---|
| ↑2 | Una prima elaborazione di questo contributo è stata presentata alla conferenza EASA 2020 nel panel della Anthropology of Race and Ethnicity intitolato “”Whose Horizons: Decolonizing European Anthropology”. La ricerca di cui tratto nell’articolo è finanziata da FAPESP, borsa di post-dottorato n. 2018/22947-3. Le opinioni, ipotesi e conclusioni espresse in questo articolo sono di responsabilità dell’autrice e non riflettono necessariamente la visione di FAPESP. |
| ↑3 | Con il termine regime di mobilità mi rifaccio alla definizione di Glick Schiller e Salazar: “Il termine “regime” chiama all’attenzione il ruolo dei singoli stati e delle mutevoli amministrazioni internazionali delle regolamentazione e della sorveglianza che condizionano la mobilità. Nello stesso tempo, il termine riflette le nozioni di governamentalità ed egemonia nelle quali è presente una costante lotta per capire, reclamare, incorporare, celebrare e trasformare categorie di somiglianza, differenza. appartenenza ed estraneità”.(Glick Schiller e Salazar, 2013, 32, mia traduzione). Molte altre definizioni sono state date dello stesso complesso di gestione della mobilità: è bene ricordare anche quello di Besteman “militarized global apartheid” (2019) o quello di “border regime” di De Genova (2016) |
| ↑4 | La nozione di Mbembe di necropolitica illumina come la violenza di stato venga messa in atto “per produrre la massima distruzione delle persone e di creare dei mondi di morte, forme nuove e uniche di esistenza sociale, nelle quali popolazioni intere sono assoggettate a condizioni di vita che equivalgono a collocarle in una condizione di “morti in vita”‘ (Mbembe, 2008, 76) |