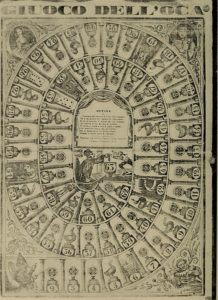Di Claudia Coppola((Formatrice referente per l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, Rennes), laureata in antropologia e scienze sociali (EHESS, Marsiglia) e in filosofia della salute (Università di Lione 3).))
Confinamento
Il mio confinamento è cominciato a Marsiglia, in un quartiere periferico della zona nord della città. Due giorni prima che il governo francese annunciasse l’inizio del lockdown, ero partita dai dintorni di Rennes – il mio luogo di residenza- per raggiungere il mio compagno e mio figlio che si trovavano a Marsiglia a casa di mia suocera. Il quartiere in cui vive mia suocera è nato come una cité((Il termine cité in francese è usato per definire un’entità architetturale e storica (un centro antico), oppure, come in questo caso, un insieme di palazzi riuniti in un’unità urbana, situati spesso alla periferia di grandi agglomerazioni, come lo sono i quartieri della zona nord di Marsiglia.)) transitoria destinata all’accoglienza di famiglie gitane e algerine emigrate dall’Africa del nord negli anni ’60. Ristrutturato nel 2000, esso si compone oggi di due schiere di palazzi dirimpettai di due piani ciascuno. La mattina del mio arrivo , il 15 marzo scorso, tutto sembrava «normale»: delle donne stendevano o raccoglievano il bucato ai balconi, degli anziani rimanevano seduti sui terrazzini dei loro appartamenti, alcuni giovani cercavano di riparare motori di macchine o motorini parcheggiati sotto casa, altri si recavano alle urne per le elezioni municipali. L’annuncio del lockdownn sarebbe arrivato il giorno seguente. Tuttavia, la mattina successiva, la stessa routine sembrava riprendere.
Il quartiere si trova letteralmente a ridosso di un asse autostradale e dei binari ferroviari. Rimanere fuori significava assorbire il rumore del traffico, cosí come dei treni e farci a poco a poco l’abitudine. Non essendoci esercizi commerciali e alimentari sul posto, né nelle zone limitrofe, dei venditori ambulanti si recano nella cité due o tre volte a settimana con viveri di ogni tipo. Il pomeriggio di quella stessa giornata, un camioncino si era parcheggiato sulla strada. Molti tra gli abitanti erano usciti senza nessuna protezione, cercando di farsi spazio, gli uni contro gli altri, per portare a casa quantità abbondanti di prodotti.
Durante i primi giorni di confinamento, osservavo i comportamenti e ascoltavo i discorsi dei vicini ai balconi: alcune persone uscivano ormai solo con guanti e mascherine; altri sembravano dubbiosi o scettici di fronte all’ emergenza sanitaria; altri raccontavano di un matrimonio gitano di una famiglia del quartiere limitrofo che avrebbe causato vari contagi nella cité; altri ancora continuavano la loro vita lavorativa senza poter fare diversamente. Commessi, guardiani, operai, assistenti a domicilio di persone isolate o impiegati delle pulizie… alcune delle persone con cui ho avuto modo di parlare in quei primi giorni di lockdown mantenevano un ritmo frenetico di lavoro. Notai che i bambini e le persone anziane del quartiere avevano cemento e un piccolo prato incolto come unico spazio di evasione, oltre ai balconi rumorosi; che i giovani continuavano a riunirsi discretamente, gli sguardi incerti sul futuro e sui cambiamenti imminenti; che la riduzione drastica degli autobus (unico mezzo pubblico che arriva alle porte del quartiere) creava disagi a tutti coloro che non disponevano di un mezzo di locomozione.
Incorporamento
Rispetto ai primi giorni del mio arrivo, una parte degli abitanti del quartiere incorporava progressivamente alcune delle norme sociali – il distanziamento fisico, in particolare – consigliate per combattere il contagio, nonostante la confusione delle fonti di informazione che circolavano. Alcuni vicini che avevo l’abitudine di salutare con una stretta di mano o con un bacio sulla guancia – saluto familiare molto diffuso in Francia – si scusavano facendomi un cenno dal balcone o parlandomi da lontano. Le persone anziane continuavano invece a ricevere le visite dei familiari e del personale di assistenza (infermieri/e, assistenti a domicilio) che arrivavano e ripartivano dal quartiere muniti di lozioni idroalcoliche e, solo pochi, di mascherine. Tensione, angoscia, discorsi contrastanti cominciavano ad esprimersi: l’impossibilità in caso di decesso di ricevere riti funebri, cosí come una sepoltura in Algeria, paese d’origine della grande maggioranza degli anziani del quartiere, sembrava una preoccupazione forte. Il disaccordo su alcune restrizioni previste dal lockdown (chiusura dei parchi e delle spiagge, divieto di riunioni familiari, chiusura delle frontiere dello spazio Schengen, ecc.) sembrava aumentare di giorno in giorno. Nella cité risuonavano voci di malcontento e al tempo stesso di rassegnazione.
Se vivere in un quartiere periferico è già in sé un’esperienza sensibile delle disuguaglianze sociali ed economiche, viverci durante un confinamento diventa uno specchio dell’inasprimento dei fattori d’esclusione esistenti, esacerbati dalle condizioni di isolamento imposte per far fronte alla crisi. La precarietà economica, la degradazione dello spazio urbano, l’estrema vicinanza alle zone industriali e la lontananza geografica dal centro, dai servizi di prima necessità e dagli spazi verdi, diventano, durante un periodo di confinamento, degli ostacoli quasi impossibili da superare . In effetti, ad 1km dal quartiere, distanza consentita per poter godere dell’ora d’aria tollerata dalla legge, non c’erano nient’altro che cemento, arterie autostradali, fabbriche e un parco chiuso. Le difficoltà sembravano moltiplicarsi giorno dopo giorno (misure di controllo degli spostamenti, tratte ferroviarie e aeree soppresse, ecc.), cosí dopo una settimana di lockdown nella cité, non senza difficoltà, sono riuscita a ripartire con la mia famiglia nel luogo del mio domicilio.
L’accesso ad alcuni boschi e spazi verdi che circondano il paesino in cui vivo, situato ad una trentina di chilometri da Rennes, è stata senz’altro una delle differenze fondamentali rispetto al contesto che avevo lasciato. Durante i primi giorni del mio ritorno, osservavo che gli abitanti circolavano nel borgo, nelle campagne, soli o in famiglia muniti – in parte – di autocertificazioni. I vicini più anziani mi raccontavano che l’autocertificazione ricordava loro i tempi della guerra, l’unico periodo a loro memoria in cui fosse necessario un documento per giustificare gli spostamenti. Non avendo né un PC né una stampante in casa, chiedevano a figli e nipoti di fornire autocertificazioni o ricopiavano il testo a mano su un foglio bianco. Spesso uscivano durante le ore meno frequentate per evitare controlli, senza rinunciare alla loro passeggiata quotidiana, né agli incontri fortuiti con altri vicini anziani ed isolati.
Molti tra gli abitanti del paese passavano il tempo nei giardini e negli spazi esterni delle loro case, impegnandosi in diverse attività : dalla creazione di piccoli orti, all’installazione di giochi per bambini, dai lavori di giardinaggio ad attività di relax in famiglia. Le discussioni dai terrazzi o dai giardini si trasformavano in momenti di incontro e condivisione: lo scambio di consigli sulle tecniche e gli strumenti di giardinaggio era intervallato dall’espressione di inquietudini sul blocco dell’economia e sul futuro dei lavori sospesi a causa della crisi. Mi è capitato di discutere con vicini professionisti del campo medico-sociale che mi confidavano le difficoltà dell’applicazione delle norme anti-covid nei loro luoghi di lavoro (istituti per persone con disabilità o difficoltà psico-sociali, case di riposo per anziani, ecc.). Il distanziamento fisico e l’uso obbligatorio di guanti e mascherine risultava spesso una fonte di tensione e di sconforto sia per i pazienti che per il personale. Lo stesso per gli/le assistenti a domicilio di persone anziane e/o malate.
Le difficoltà derivate dalla chiusura delle scuole erano argomento di discussione nel vicinato. La sospensione dei legami sociali e delle dinamiche di incontro dei bambini e degli adolescenti, cosí come la complessità della pedagogia da casa, cominciavano ad avere un certo impatto sulla quotidianità delle famiglie. Malgrado la chiusura dei luoghi di ritrovo e dei siti naturali (fiumi e laghi in particolare), il piccolo parco del paese è rimasto aperto durante tutta la fase di lockdown. Poco frequentato, tale luogo ha concesso brevi istanti di evasione, soprattutto ai più piccoli. Tuttavia, la sua apertura ha spesso suscitato le proteste di una parte degli abitanti, alimentando la sorveglianza e la delazione da parte del vicinato di comportamenti considerati «non conformi» (contatto fisico, ritrovi, ecc.). Contrariamente agli episodi di denuncia, nel contesto locale sono emerse anche forme di solidarietà: alcune persone hanno aperto i loro giardini per permettere ai vicini di goderne liberamente; altre hanno condiviso la loro abitazione durante il periodo del lockdown con familiari anziani o con amici isolati; altre ancora hanno offerto regolarmente il loro aiuto per la spesa o per commissioni di altro tipo.
L’atmosfera calma e gradevole del piccolo paese della campagna bretone non è stata dunque preservata dalle tensioni suscitate dall’isolamento e dalle restrizioni della libertà di circolazione. La spontaneità nello scambio di oggetti, le visite a domicilio, gli incontri e gli spostamenti al di là di 1km senza ragioni impellenti sono stati per molti episodi rari o per lo meno discreti, nonché caratterizzati da un distanziamento fisico pronunciato. Se dunque l’osservanza delle norme imposte per la gestione della crisi è stata in parte integrata come una forma legittima di protezione dal contagio, essa ha provocato una sorta di frattura sociale, accentuando al tempo stesso l’esclusione di persone già isolate, gli anziani in particolare. La paura, la diffidenza e gli episodi di denuncia, cosí come il disaccordo di alcuni abitanti sulle restrizioni del lockdown, hanno contrassegnato la prima fase di confinamento, lasciando emergere emozioni contrastanti.
Riflessioni
Tale esperienza di sospensione e di regolamentazione delle relazioni sociali, imposta come unica soluzione all’emergenza sanitaria, apre uno spazio di riflessione sul processo di elaborazione e di incorporazione dei processi normativi e sui rapporti di dominazione che ne conseguono, tematiche trattate da Michel Foucault (1975 ; 1978-79). Osservando la situazione attuale, potremmo dunque valutare le possibilità di cambiamento micro e macro-sociale, le capacità normative e «normalizzanti»((M. Foucault definisce la normalizzazione come un esercizio sottile del potere che agisce sul corpo sociale e sulle soggettività attraverso strategie e dispositivi capillari il cui compito sarebbe quello di controllare, diagnosticare e risanare i comportamenti devianti sulla base delle norme stabilite. Secondo M. Foucault, la medicina è una disciplina portatrice di tecniche di normalizzazione e di potere : il riferimento dei dispositivi di potere alle norme mediche si rivela, secondo il filosofo, una delle principali caratteristiche delle società moderne (La naissance de la biopolitique, Cours au collège de France, 1978-1979 ; Surveiller et punir, 1975))) dell’apparato politico e istituzionale delle società colpite dalla pandemia, cosí come le nuove forme di solidarietà che potrebbero sorgere dalla crisi sanitaria. Le norme di distanziamento sociale, il controllo della libertà di circolazione (durata, spazio e legittimità degli spostamenti), la chiusura delle frontiere dello spazio Schengen resteranno misure eccezionali limitate al periodo e al contesto della crisi sanitaria, oppure riscuoteranno un consenso sociale e politico tale da giustificare l’adozione permanente di tecniche e strategie di controllo di fronte all’ipotesi di ritorno del contagio ? Allo stesso modo, il confinamento imposto dall’emergenza sanitaria può contribuire allo sviluppo durevole di nuove solidarietà, di nuovi supporti educativi, di nuove pratiche virtuali (lavoro da casa, tele-consultazioni, ecc.), di un rapporto più consapevole alle risorse naturali, e fare di noi degli attori della creazione di pratiche inedite e di nuovi legami sociali?
Certo, il modello di sviluppo occidentale e il suo apparato ideologico fondato sull’idea del progresso e della produttività rivelano più che mai le loro lacune e le loro fragilità. La morte, bandita e relegata al margine delle nostre vite, fa oggi irruzione improvvisamente nella nostra quotidianità, mettendoci sempre più a contatto con la transitorietà delle nostre esistenze, con la finzione del mito della longevità e con la precarietà del sistema sanitario dei paesi dalle economie post-industriali. L’esposizione sempre più forte alla malattia e al contagio mettono in evidenza la non onnipotenza/la fallibilità dei saperi della scienza e della biomedicina. Il solo linguaggio matematico dell’esattezza, della precisione, della classificazione, della spiegazione razionale emancipata dalle ambiguità e dai rischi di interpretazione che, come sostenuto da Foucault (2009), la medicina ha adottato già dalla fine dell’epoca moderna, sembra oggi inadeguato per la comprensione della crisi sanitaria. Domande senza risposta, cause e conseguenze del virus sconosciute e mutevoli, prospettive incerte: il tutto rivela la parte di indeterminatezza, il ruolo dell’interpretazione e la dimensione sociale del discorso scientifico (Khun, 1983).
E se fossimo di fronte ad un limite, che necessita di nuove ermeneutiche e nuove maniere di stare al mondo? Nuovi sguardi e approcci critici, un ridimensionamento del nostro antropocentrismo e l’esortazione a nuove solidarietà tra nazioni (per ora ancora chiuse su sé stesse) potrebbero essere i prossimi passi da intraprendere.
Riferimenti di lettura
Foucault M.
re-ed. 2009, « Naissance de la clinique », PUF, Paris
ed. 1975, « Surveiller et punir », Gallimard, Paris
ed.1978, « La naissance de la biopolitique. Cours au collège de France 1978-1979», Gallimard, Seuil, Paris
Khun T. S., ed.1983 « La structure des révolutions scientifiques», Flammarion, Paris